Il 16 ottobre 1943 e "La parola ebreo" di Rosetta Loy
- Claudio Orlandi
- 16 ott 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 9 feb 2025
Il 16 ottobre del 1943, il "sabato nero" del ghetto ebraico di Roma. Alle 5.15 del mattino le SS di Kappler invadono le strade del Portico d'Ottavia e rastrellano 1023 persone, tra cui oltre 207 bambini. Due giorni dopo, alle 14.05 del 18 ottobre, diciotto vagoni piombati partiranno dalla Stazione Tiburtina. Dopo sei giorni arriveranno al campo di concentramento di Auschwitz in territorio polacco. Solo quindici uomini e una donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno a casa. Nessuno dei bambini è mai tornato.
“16 ottobre 1943” è nominato il testo che Giacomo Benedetti – dismessi i panni del critico e indossati quelli dell’autore - ha lasciato a memoria degli eventi di quella giornata, un vero e proprio classico. Pubblicato per la prima volta nel dicembre 1944, dalla rivista “Mercurio” di Roma, in un numero dedicato alla Resistenza. Fu subito ripreso da “Libera stampa di Lugano”; nel 1947 J.P. Sartre lo fece tradurre per “Temps Modernes; nel 1955 la rivista “Galleria” lo mise al centro del suo fascicolo per il decennale della Liberazione.
Oltre al testo di Benedetti vorrei qui segnalare il libro di Rosetta Loy “La parola ebreo”. Un testo di assoluta eleganza e forza, nel quale l'autrice riesce a tracciare in modo agile, il rapporto storico tra cultura italiana e antisemitismo, e il percorso che in pochi anni ha visto l’innesto e lo sviluppo dell’abominio razzista anche in Italia, fino a quelle leggi razziali (1938) che hanno rappresentato l’anticamera dei campi di sterminio. Particolarmente dettagliata l’annosa questione del ruolo della Chiesa cattolica, che ha finito per silenziare ogni voce interna di dissenso nei confronti delle politiche antisemite. Significativa la svolta che si ebbe nel passaggio tra Papa Pio XI e Pio XII.
Achille Ratti (Pio XI) muore infatti il 10 febbraio 1939 e non vedrà mai la luce l’enciclica Humani Generis Unitas, che avrebbe espresso una esplicita condanna del nazismo come culto pagano, del razzismo e della persecuzione degli ebrei. Come noto, il successore Pio XII eviterà di esprimersi sull’antisemitismo e gli ebrei, e non farà accenno al nazismo o alla politica espansionistica di Hitler.
Scrive Loy “Ci vorranno 33 anni perché si possa sapere almeno in parte quale era la volontà di Pio XI e cosa probabilmente aveva intenzione di dire ai vescovi quell’11 febbraio 1939. E ce ne vorranno 56, di anni, per arrivare a conoscere il testo dell’enciclica Humani Generis Unitas preparata dietro sua richiesta da un gesuita franco-americano (John LaFarge)”.
La bozza del testo rimarrà infatti segreta fino al 1995 quando verrà pubblicata in Francia da G. Passelecq e B. Suchecky col titolo L'Encyclique Cachée de Pie XI, e poi nel 1997 in inglese intitolata The Hidden Encyclical of Pius XI.
Sappiamo però, che nessuno riuscirà più a fermare – né tenterà di farlo - il delirio criminale nazista.
“Il 20 gennaio 1942, durante la Conferenza che si tiene a Wannsee sotto la presidenza di Reinhard Heydrich, mentre lo sguardo dei maggiori responsabili della politica del Reich svaga sui laghi e i bellissimi boschi che circondano Berlino, viene segretamente decisa per gli ebrei <la soluzione finale>, pallido eufemismo per significare il loro sterminio totale.
Non che gli eccidi di massa non siano già cominciati. Da quando, nella primavera del 1941, sono stati istituiti gli Einsatzgruppen, si calcola che siano già state uccise 800.000 persone fra ebrei e comunisti, in maggioranza nei paesi dell’est. Ma la soluzione finale prevede la morte di circa undici milioni di ebrei e l’organizzazione da mettere in atto deve essere perfetta e estremamente efficiente e rapida. Per superare l’ostacolo che rappresenta l’eliminazione fisica di milioni di persone viene deciso il campo di sterminio modello Birkenau, a qualche chilometro da quello ricavato dalle ex caserme dove la I. G. Farbenindustrie ha posto all’ingresso la scritta di ferro battuto: Arbeit Macht Frei, che figura davanti a tutte le sue fabbriche.”
Come detto, in Italia, le leggi razziali rappresentarono l’anticamera dei campi di sterminio per la realizzazione della soluzione finale:
“Nel censimento del 1938 gli ebrei romani erano circa 12.000. Nell’ottobre del 1943 – scrive Rosetta Loy – è difficile sapere quanto ne erano rimasti, e quanti invece erano confluiti dal nord nella speranza che Roma fosse più sicura. All’alba del 16 ottobre i tedeschi riuscirono a catturarne 1259. Era sabato (sempre il sabato sceglievano i tedeschi perché sapevano che era più facile trovare le famiglie riunite) e dalle quattro del mattino avevano cominciato a sparare fra le strade del ghetto per impedire a chiunque di uscire. Tutto si è svolto con estrema velocità. Svegliati con dei forti colpi alla porta, gli uomini, le donne, i vecchi e i bambini, hanno avuto venti minuti di tempo per vestirsi e radunare il cibo per otto giorni, fare una sommaria valigia e prendere il denaro che avevano in casa (denaro che lestamente i tedeschi provvederanno a portargli via fino all’ultima lira).”

Giacomo Benedetti, 16 ottobre 1943, Einaudi 2001
Rosetta Loy, La parola ebreo, Einaudi, 1997
David Kertzer, Il patto col diavolo. Mussolini e Papa Pio XI. Le relazioni segrete fra il Vaticano e l'Italia fascista (The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe, 2014), traduzione di L. Clausi, Collana Saggi stranieri, Milano, Rizzoli, 2014.
La conferenza (Die Wannseekonferenz) è un film per la televisione del 2022 diretto da Matti Geschonneck.





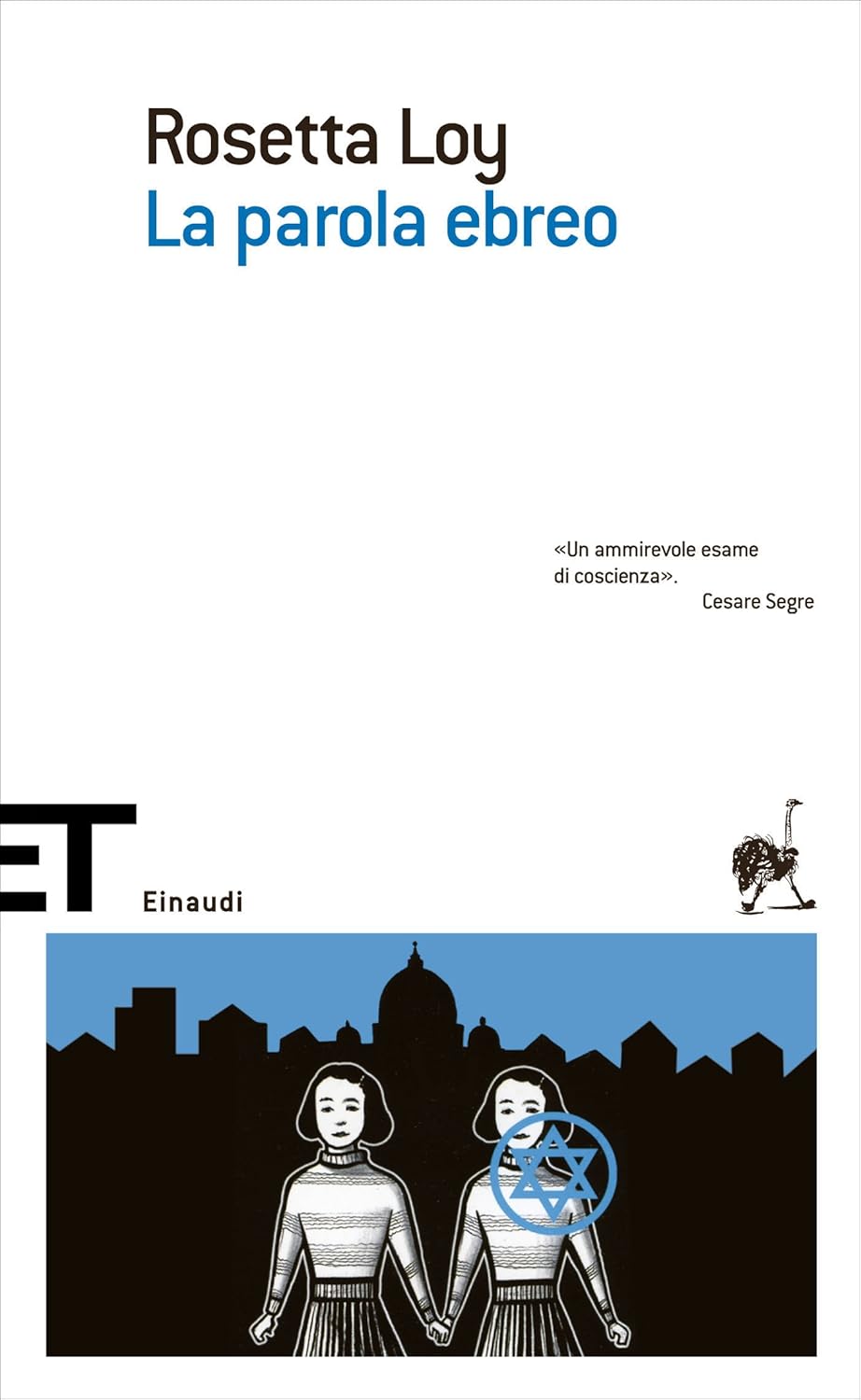


Commenti