Costruire il nemico, di Umberto Eco
- Claudio Orlandi
- 8 apr 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Costruire il nemico, di Umberto Eco
Stralci
Avere un nemico è importante non solo per definire la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare il nostro sistema di valori e mostrare, nell'affrontarlo, il valore nostro. Pertanto quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo.
Tuttavia sin dall'inizio vengono costruiti come nemici non tanto i diversi che ci minacciano direttamente (come sarebbe il caso dei barbari), bensì coloro che qualcuno ha interesse a rappresentare come minacciosi anche se non ci minacciano direttamente, così che non tanto la loro minacciosità ne faccia risaltare la diversità, ma la loro diversità diventi segno di minacciosità.
Pare che del nemico non si possa fare a meno. La figura del nemico non può essere abolita dai processi di civilizzazione. Il bisogno è connaturato anche all'uomo mite e amico della pace.
Nel 1968 era stato pubblicato in America un Rapporto da Iron Mountain sulla possibilità e desiderabilità della pace, di Anonimo – qualcuno lo aveva persino attribuito a Galbraith – (a cura di I.C. Lewis, Dial Press 1968). Chiaramente si trattava di un pamphlet contro la guerra, o almeno di un lamento pessimistico sulla sua inevitabiltà. Ma poiché per fare la guerra ci vuole un nemico con cui guerreggiare, la ineluttabilità della guerra corrisponde alla ineluttabilità dell'individuazione e della costruzione del nemico. Così con estrema serietà in questo pamphlet si osservava che la riconversione dell'intera società americana a una situazione di pace sarebbe stata disastrosa perché solo la guerra costituisce il fondamento dello sviluppo armonico delle società umane. Lo spreco organizzato della guerra costituisce una valvola che regola il buon andamento della società. Solo la guerra risolve il problema delle scorte; è un volano. La guerra permette a una comunità di riconoscersi come "nazione"; senza il contraltare della guerra un governo non potrebbe neppure stabilire la sfera della propria legittimità; solo la guerra assicura l'equilibrio tra le classi e permette di collocare e sfruttare gli elementi antisociali. La pace produce instabilità e delinquenza giovanile; la guerra incanala nel modo più giusto tutte le forze turbolente dando loro uno "status". L'esercito è l'ultima speranza dei diseredati e dei disadattati; solo il sistema di guerra, col suo potere di vita e di morte, dispone la società a pagare un prezzo di sangue anche per altre istituzioni che non ne dipendono, come lo sviluppo dell'automobilismo.
Ecologicamente la guerra provvede una valvola di sfogo per le vite in eccedenza; e se sino al XIX secolo vi morivano solo i membri più validi del corpo sociale (i guerrieri) mentre si salvavano gli inetti, i sistemi attuali hanno permesso di superare anche questo problema con i bombardamenti sui centri civili. Il bombardamento limita l'aumento della popolazione meglio che l'infanticidio rituale, la castità religiosa, la mutilazione forzata o l'uso estensivo della pena di morte… Infine è la guerra che consente lo sviluppo di un'arte veramente "umanistica", in cui predominino le situazioni di conflitto.
*
Nella parte finale Eco cita un passo dal 1984 di Orwell, precisamente quello inerente i “Due Minuti d’Odio” che devono essere rivolti al rinnegato, l'apostata, il Nemico del Popolo, Emmanuel Goldstein:
«Goldstein stava sferrando il suo solito velenoso attacco alle dottrine del Partito… domandava l'immediata conclusione della pace con l'Eurasia, chiedeva libertà di parola, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di pensiero, e strillava, quasi in un accesso d'isterismo, che la rivoluzione era stata tradita. [...]
Prima ancora che fossero passati una trentina di secondi d'Odio, incontrollabili manifestazioni di rabbia ruppero fuor da una metà del pubblico nella sala…. Durante il suo secondo minuto, l'Odio arrivò fino al delirio. La gente si levava e si rimetteva a sedere con gran rimestio, e urlava quanto più poteva nello sforzo di coprire il belato di quella voce maledicente che veniva dallo schermo. La donnetta dai capelli color sabbia era diventata rossa come un peperone e apriva e chiudeva la bocca come un pesce tratto fuor d'acqua… La bruna dietro a Winston aveva cominciato a strillare: "Porco! Porco! Porco!" e tutt'a un tratto afferrò un pesante dizionario di neolingua e lo scaraventò sullo schermo. Questo andò a colpire diritto il naso di Goldstein e poi ricadde a terra: la voce continuava inesorabile.
(fotogramma da Orwell 1984 (Nineteen Eighty-Four) sceneggiato e diretto da Michael Radford)
In un momento d'improvvisa lucidità, Winston si accorse che anche lui stava strillando come tutti gli altri, e batteva furiosamente i tacchi contro il piolo della sedia. La cosa più terribile dei Due Minuti d'Odio non consisteva tanto nel fatto che bisognava prendervi parte, ma, al contrario, proprio nel fatto che non si poteva trovar modo di evitare di unirsi al coro delle esecrazioni… Una fastidiosa estasi mista di paura e di istinti vendicativi, un folle desiderio d'uccidere, di torturare, di rompere facce a colpi di martello percorreva l'intero gruppo degli astanti come una sorta di corrente elettrica, tramutando ognuno, anche contro la sua stessa volontà, in un paranoico urlante e sghignazzante».
*
Stralci dell'intervento tenuto da Umberto Eco il 15 maggio 2008 all’Università di Bologna, nell’ambito delle serate sui classici e apparso in Ivano Dionigi (a cura di) “Elogio della politica”, in seguito ripubblicato in Umberto Eco, Costruire il nemico e altri scritti occasionali. Qui il testo integrale ripubblicato per La nave di Teseo 2020.









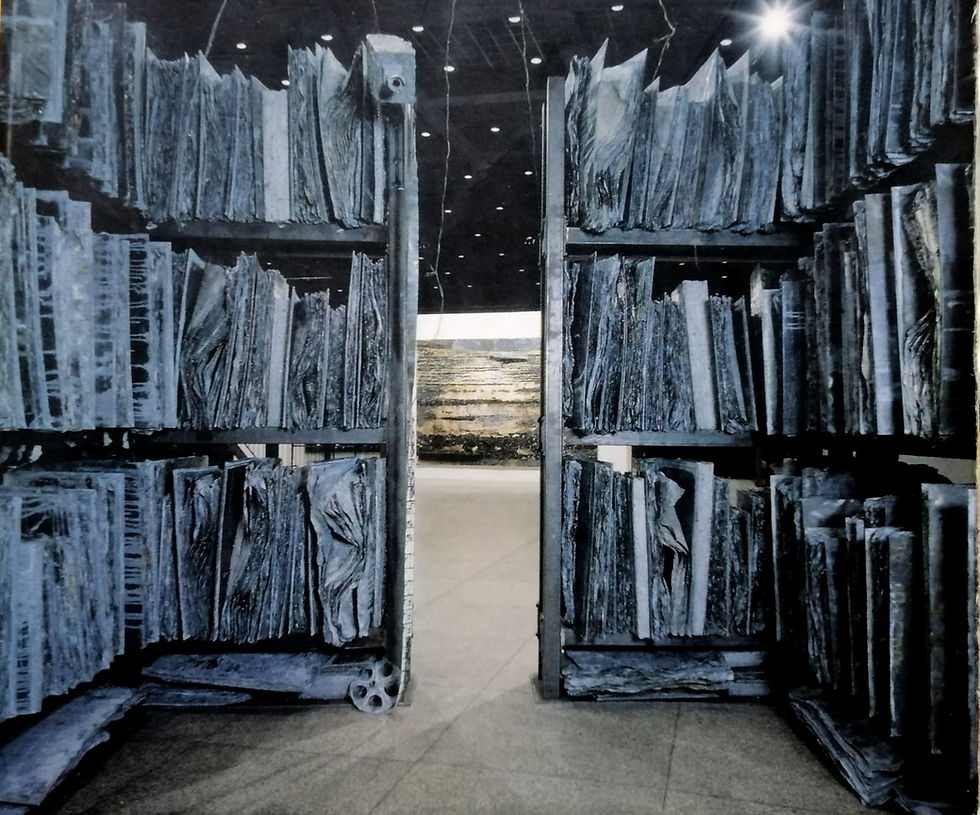

Commenti