Masha Gessen, Gaza come un ghetto
- Claudio Orlandi
- 15 dic 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 1 mar 2024
A quanto pare in Germania, di questi tempi è molto complicato parlare ed esprimere liberamente le proprie opinioni sulla situazione palestinese senza essere accusati di puro antisemitismo. Ovviamente è una stortura, una forma di ricatto intellettuale inaccettabile, soprattutto a seguito alla catastrofe umanitaria di Gaza. A tal proposito l'intellettuale russa di origine ebraica Masha Gessen, (nota per i suoi scritti sulle tematiche LGBT e la decennale opposizione al Presidente Putin), si è espressa in modo chiaro in un recente articolo sul New Yorker, dal titolo "All'ombra dell'Olocausto", nel quale ha paragonato la Striscia di Gaza a un ghetto ebraico durante l’occupazione nazista dell’Europa, e per questo sta subendo un netto ostracismo, fino alla parziale sospensione della consegna del premio Hannah Arendt da parte della Fondazione Heinrich Böll.
Nell'articolo citato, sottotitolato "Come la politica della memoria in Europa oscura ciò che vediamo oggi in Israele e Gaza", Gessen si incarica anche di analizzare in quali condizioni la culturta tedesca approcci la questione israelo-palestinese, avendo alle spalle la tragedia della Shoa. Un compito non facile che deve aver toccato i nervi più sensibili del corpo sociale tedesco, che infatti ha reagito negativamente.
Sul piano della libertà di espressione, ogni giorno dobbiamo ormai fare i conti con questo assetto illiberale anche nelle "democrazie occidentali". Un potere atlantico, sempre più a forma di Cupola, dirama direttive e condanne, decide eresie e processi. La libertà di pensiero ed espressione è uno dei pilastri del regime democratico, ed è dovere di ogni persona che si risoconosca in questi diritti-valori lottare affinchè il loro esercizio non venga ostacolato.
«Negli ultimi 17 anni, Gaza è stata un compound iper-densamente popolato, impoverito, chiuso da mura, che solo una piccola frazione della popolazione ha potuto lasciare, e sempre per brevi periodi di tempo. In altre parole, un ghetto. Ma non come il ghetto ebraico di Venezia, o il ghetto di una città americana: bensì un ghetto ebraico in un qualche Paese dell’Europa orientale, occupato dalla Germania nazista. Nei due mesi dacché Hamas ha attaccato Israele, tutti i cittadini di Gaza hanno sofferto per l’initerrotto fuoco delle forze israeliane. In migliaia sono morti. In media, un bambino viene ucciso ogni dieci minuti. Le bombe israeliane hanno colpito ospedali, reparti di maternità, ambulanze. Otto cittadini di Gaza su dieci si ritrovano senza casa, costretti a muoversi da un posto all’altro, senza mai trovare sicurezza».
Masha Gessen
All'ombra dell'Olocausto, 9.12.23
p.s.
Masha Gessen è tornata a parlare della questione in un’intervista a Democracy Now tenuta il 15 dicembre, durante la quale ha ulteriormente specificato il suo ragionamento, qui un estratto:
«Il paragone che faccio tra Gaza e un ghetto ebraico è intenzionale, non è provocazione. È proprio questo il punto: il modo in cui funziona oggi la politica della memoria in Europa e negli Stati Uniti e in particolare in Germania è che non si può paragonare l'Olocausto a nulla. È un evento singolare che si colloca al di fuori della storia. La mia tesi è che per imparare dalla storia dobbiamo fare paragoni. Deve essere un esercizio costante. Non siamo persone migliori, né più intelligenti, né più istruite di quelle vissute 90 anni fa. L'unica cosa che ci rende diversi è che nella loro immaginazione l'Olocausto non esisteva ancora. Nella nostra sì. Sappiamo che è possibile. Il modo per prevenirlo è essere vigili come è stata Hannah Arendt e come lo furono altri pensatori ebrei sopravvissuti all’Olocausto. C’è stato un discorso, soprattutto nei primi due decenni dopo la seconda guerra mondiale, in cui si parlava proprio di come riconoscere i segni dello scivolamento nell'oscurità. Il nostro diritto internazionale umanitario si basa essenzialmente sull’Olocausto, così come il concetto di genocidio. E io sostengo che questo quadro si basa sul presupposto che si guardi sempre alla guerra, al conflitto, alla violenza attraverso il prisma dell’olocausto. Bisogna sempre porsi la domanda se i crimini contro l'umanità siano ricorrenti. Israele ha condotto una campagna di incredibile successo non solo collocando l’Olocausto al di fuori della storia, ma isolandosi anche dall’ottica del diritto umanitario internazionale, in parte utilizzando come arma la politica della memoria e la politica dell’Olocausto. Penso che l’unico modo per cercare di garantire che l’Olocausto non accada più sia sapere che è possibile, continuare a sapere che può nascere da quella che Arendt chiama superficialità e che riporta ne “La banalità del male”. Per questo libro fu ostracizzata sia dal mainstream politico israeliano che da gran parte del mainstream politico ebraico nordamericano. Fu interpretato come una banalizzazione dell'Olocausto, ma quello che dice è che le cose più orribili di cui l’umanità si è dimostrata capace possono nascere da qualcosa che sembra niente, dall'incapacità di vedere il destino dell'altro. Lo interpreto come un appello a dubitare del tipo di consenso schiacciante che certamente in Israele e nella comunità ebraica nordamericana sembra sostenere l’assalto israeliano a Gaza. Perché è così che inciampiamo nei nostri momenti più bui».

Masha Gessen nata a Mosca nel 1967, si è spostata con la famiglia negli Stati Uniti nel 1981 per tornare in Russia dieci anni dopo e lavorare come giornalista. È stata redattrice capo della più longeva rivista russa, Vokrug sveta, e nel dicembre 2013 è tornata a stabilirsi negli USA, a New York, a causa delle minacce legali rivolte alla comunità gay. Si qualifica come «non-binario», è attivista LGBT e per questo usa per definirsi in inglese i pronomi neutri they/them (loro). Ha iniziato a collaborare al New Yorker nel 2014 e vi scrive regolarmente dal 2017. È autrice di diversi libri, tra cui “Surviving Autocracy”, "The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin" e “The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia”, (Il futuro è storia) con il quale ha vinto il National Book Award. Si occupa di Russia, Ucraina, autocrazia, comunità LGBT, diritti umani, Vladimir Putin e Donald Trump. Il ministero degli Interni russo ha inserito il suo nome nella sua lista di ricercati. Ha affrontato anche temi di natura scientifica, scrivendo di AIDS, genetica medica e matematica. Nota anche per aver subito licenziamento come redattore della rivista scientifica popolare russa “Vokrug sveta” per essersi rifiutata di mandare un giornalista a osservare Putin mentre volava in deltaplano con le gru siberiane. Nel 2012 Sellerio ha pubblicato il suo libro "L'uomo senza volto. L'improbabile ascesa di Vladimir Putin".





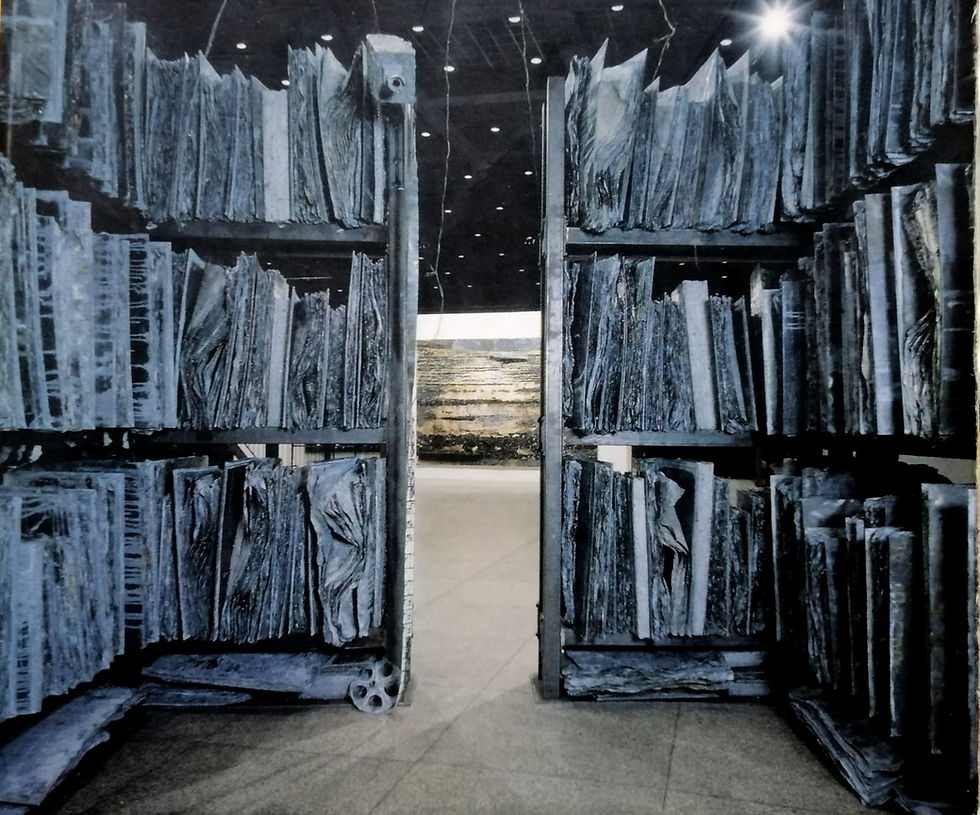

Commenti