“Yoga - La composizione delle tecniche come strumento per ritrovare una pratica viva” di Francesca Proia
- Claudio Orlandi
- 15 apr 2025
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 14 mag 2025
Vorrei qui richiamare l’attenzione su un testo che mi ha accompagnato nella lettura negli ultimi mesi. “Yoga” di Francesca Proia, sottotitolo “La composizione delle tecniche come strumento per ritrovare una pratica viva”, libro pubblicato nel 2022, dalla casa editrice Astrolabio – Ubaldini Editore.

Le domande poste dall’autrice ad apertura del testo rendono subito chiare per quali vie sarà iscritto l’ambito della ricerca:
“La domanda alla base di questo libro è: perché, oggi fare yoga? Qual è il suo ambito specifico di azione e quale una sua possibile posizione nello schema occidentale delle discipline che sempre ci portano a scegliere tra corpo e mente? Come può, lo yoga, trovare finalmente uno spazio in cui le comunità del presente gli riconoscano una dignità di strumento efficace dotato di un’azione peculiare non assimilabile ad altre esperienze? Come si può raccogliere la ricca eredità della tradizione senza essere, nella pratica, in un passato fossile e dogmatico? E infine, che tipo, di esperienza porta lo yoga, da un punto di vista corporeo, filosofico, conoscitivo, percettivo?”
Mostrando una capacità non scontata di visione e capacità di sintesi, l’autrice ci propone subito dopo le prime risposte:
“Lo yoga è una disciplina molto simile alla filosofia poiché, proprio come fa la filosofia, conduce il praticante alla produzione di intuizioni che rifondano il proprio modo di percepire la realtà. Lo yoga è una disciplina che produce intuizioni che però hanno la particolarità di essere preparate nel corpo, attraverso le esperienze percettive predisposte dalle tecniche”.
“Lo yoga – ci dice Proia – non ha paragoni perché finisce per configurarsi come una pratica che, una volta intrapresa, lascia prendere le redini all’inconfondibile senso di direzione interiore che sorge attraverso la pratica, così che le tecniche, a partire da un certo punto in poi, smettono di dirigere e finiscono piuttosto per costeggiare l’esperienza, senza imporsi ma supportando, filtrando, fissando, punteggiando l’evento della psiche che incontra se stessa nel corpo.”
Dopo una breve ma incisiva introduzione siamo pronti per immergerci nel testo vero e proprio, diviso in tre parti:
Prima parte – Lo sviluppo dello yoga tra Oriente e Occidente
Seconda parte – Modi e forme della composizione yogica
Terza parte – trovare la strada
La prima parte – una storia documentata dello yoga - consente al lettore di conoscere gli aspetti storico teorici dello yoga dagli albori a oggi e di prendere così familiarità con il lessico basilare, utile a comprendere il complesso universo yogico. Si viene dunque introdotti all’interno del corpus vedico, a partire dalle prime raccolte dei Veda sino ai Sutra e i Vedanda, passando per le elaborazioni teoriche delle Upanisad. Infatti se in origine era una pratica inseparabile da una mistica popolare fondata sul culto della natura e dell’energia, è attraverso le Upanisad che lo yoga diviene una disciplina più definita e complessa.
Sul piano storico, “Si potrebbe affermare – scrive l’autrice - che lo yoga esiste da sempre e collocare la sua vera origine (più che nella storia) nei territori interni, fissandone la vera nascita nel contatto con quelle isole interiori nelle quali domina la percezione intuitiva che il tempo sia uno stato piuttosto che un dato di fatto. Questa intuizione, che riguarda la possibilità di separarsi consapevolmente dal tempo e di sospendersi entro una prospettiva inedita, arriva proprio grazie all’incontro con questi sporadici nuclei psichici che sembrano intangibili dal tempo, misteriose nubi nella quali talvolta si incappa, nuclei più vivi del vivente stesso e che sembrano contenere il segreto di tutto. Nuclei che hanno un potenziale mitico, e che fanno fare esperienza di una mente screziata di divino, sentito come un presentimento che eccede l’umano. Il desiderio di scavare in tali bacini, di poter aderire a questa possibilità e in definitiva di ridurre la preponderanza dell’umano e delle sofferenze connesse, ha portato allo yoga. Quanto al corpo, ha da sempre un ruolo necessario per poter, banalmente, dare tutto di sé, per intensificare la presenza. Le tecniche corporee dello yoga riposano implicitamente sulla coscienza innata delle interazioni profonde che esistono tra corpo e pensiero”.
Questa prima parte si snoda quindi attraverso la descrizione generale dell’ampio spettro del vedismo, dei primi riferimenti teorici e pratici che ritroviamo nelle Upanisad, nelle quali è già possibile riscontrare le differenziazioni tra Mantra yoga, Laya yoga, Hatha yoga e Raja yoga. Si giunge in seguito a tempi relativamente più recenti, a partire dal IV sec. d.C. ai sei darsana (Mimamsa, Vedanta, Nyaya, Vaisesika, Yoga e Samkhya), quali sistemi teorici compiuti, tentativi di spiegazione del rapporto tra fisica e metafisica. È questo l’ambito nel quale lo Yoga, “darsana tra i darsana, raggiunge lo status di filosofia autonoma, configurandosi come una delle sei scuole di pensiero ortodosso della filosofia indiana”.

L’autrice dedica ampio spazio all’analisi di alcuni dei testi fondanti dello yoga, in particolare Yoga Sutra di Patanjali (di datazione incerta, ma con ogni probabilità la sua stesura finale va collocata fra il V e il VI secolo d.C.). È infatti grazie a Patanjali, sotto al cui nome potrebbe in ogni caso celarsi non per forza una persona sola, che lo Yoga si trasforma in sistema filosofico. In pratica lo Yoga come darsana è una metodologia del Samkhya: prendendo le tecniche fino a qui note, si dà vita a un sistema che porta a compimento le premesse filosofiche del Samkhya, concentrandosi intorno all’idea che sia necessario all’uomo trovare una via che sbocchi su un piano metafisico atemporale, per sfuggire alla sofferenza della temporalità, e non lasciarsi così esaurire dal tempo.
Come detto, il testo accompagna il lettore a prendere familiarità con i termini, i concetti, che vanno a formare la galassia yogica. A partire dagli otto aspetti elencati negli Yoga Sutra (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi), il testo riesce a dare contezza delle categorie intorno alle quali evolve e si sviluppa la pratica e la ritualità dello yoga. Affronterà poi in modo esteso gli aspetti teorico pratici dell’Hatha yoga, con paragrafi dedicati ad Hatayoga Pradipika, Siva Samhita e Gheranda Samhita, fino ad aprire uno spazio di profonda riflessione dedicato a Kundalini, alla coscienza tantrica e al Tantra, nella sua connessione con l’Hatha yoga.

La parte si chiude con un paragrafo titolato “Lo yoga in Occidente”, che ho trovato di particolare interesse. Qui l’autrice, passando in rassegna le figure di maggior spicco impegnate su questa strada, illustra in modo sintetico ma efficace tempi e modi della diffusione dello yoga in Occidente, nel “desiderio di far accettare lo yoga a una platea molto più vasta rispetto alle appartate correnti indiana di praticanti.”
Infatti a partire dalla metà dell’Ottocento, lo yoga (grazie al lavoro di una serie di persone che fanno parte dell’epica moderna della storia yogica) è entrato – potremmo dire – in una nuova fase, subendo un processo di espansione e trasformazione che lo ha reso sempre più popolare.
Ma “Lo yoga – spiega Proia – è arrivato in Occidente ridotto al minimo: edulcorato, esaltato nei suoi aspetti affini alle pratiche ginniche e religiose già familiari agli occidentali, solo più esotiche… e forse non sarebbe stato possibile diffonderlo in altro modo all’inizio, vista la diffidenza e la repulsione riservata agli yogin dai coloni inglesi in India”.
Tuttavia “Se si considera tutta l’evoluzione dello yoga fino a oggi, si può notare che nulla è stato compromesso o degradato: lo yoga porta in sé la propria efficacia, e osservando la sua storia, è abbastanza evidente come tutto ciò che non va nel senso di un trattamento filologico della disciplina sia destinato a una vita effimera, poiché non compete in efficacia con uno yoga che sia fedele alle sue premesse. La discriminante è sempre e solo l’efficacia che si dipana da una pratica intatta, una pratica, che non perde il filo”.

“Immaginiamo lo yoga come un mare a nostra disposizione; dimentichiamoci per un momento gli stili appresi, le regole. Dimentichiamoci le origini dello yoga e l’aura di soggezione con cui ci si appresta a volte a praticare. Cosa resta?
Abbiamo le tecniche. Se le abbiamo imparate correttamente, ogni tecnica dovremmo poterla presentire come una cellula, un fonema autonomo e generante senso.”
Questo è lo spirito con la quale l’autrice affronta e propone nella Seconda parte del libro la questione della composizione delle tecniche (la composizione yogica), come strumento per ritrovare una filologia della pratica che sia viva. Infatti dobbiamo sempre tenere presente che accanto alla teoria, nello yoga è fondamentale il coinvolgimento del corpo “poiché il corpo è il recettore dell’esperienza percettiva”, che può dirsi il carburante dello yoga come filosofia.
“La pratica della composizione permette di soppesare le tecniche attraverso rapporti reciproci; è simile a un’alchimia che produce effetti ogni volta differenti. Per ricavare dall’alfabeto una materia viva è necessario comporre lettere; ugualmente, per ricavare una materia viva dalle tecniche, noi le componiamo”.
Ecco dunque che asana, pranayama, mudra, potranno essere composti come una scultura, o una composizione musicale.
Vengono di seguito riportati tre esempi di poetica compositiva di maestre di yoga del Novecento (care all’autrice), nella cui pratica il tema della composizione è evidente per motivi differenti, e in cui è chiaro il rapporto tra composizione ed efficacia della disciplina: Genevieve Stebbins (1857-1934), assistente di François Delsarte, che ha dato vita a un sistema di ginnastica in cui le tecniche del corpo e del soffio si intrecciano attraverso connessioni concettuali; Cajzoran Ali (1903-?) rimasta quasi sconosciuta, che ha ideato una sequenza trasformativa di quarantotto posture utilizzando come guida le reazioni del suo corpo malato fin dalla nascita, e infine Noëlle Perez Christiaens (1925-2019), allieva di Iyengar, che ha riorientato le tecniche in base al concetto antropologico di aplomb come risorsa terapeutica naturale, da riscoprire e riportare nel proprio corpo attraverso il contatto con le culture tradizionali e arcaiche.
Nella Terza parte Francesca Proia, evidentemente forte di una propria esperienza sul campo, nel concludere il volume resta concentrata sulla pratica della composizione delle tecniche, sottolineando un aspetto a volte sottovalutato dello yoga, ossia che ogni parametro può essere riconsiderato, in quanto “lo yoga dovrebbe scardinare costantemente i differenti tipi di condizionamento, reinterrogare ciò che è dato per scontato”.
“La pratica della composizione delle tecniche avviene a partire dal nulla: aspettando, lasciando sbocciare percezioni e inventando così, ogni volta, una sequenza che come un filo attraversa il tempo sfiorando le tecniche, ritrovando l’origine delle stesse nella genetica della specie umana, modi e forme del mistero della presenza”.
Ecco allora un’analisi del popolare “Saluto al sole” (probabilmente nato come preparazione per esibizioni fisiche, sportive o parate militari); le esperienze di comunione tra yoga e composizione musicale in autori come Giacinto Scelsi ed Edward Salim Micheal; un approfondimento sul tema della polarità e la possibilità di comporre attraverso l’utilizzo del glifo dell’Albero della Vita, metodo ideato dall’autrice osservando la simmetria tra Cabala e Hatha yoga.
*
Dunque lo Yoga è giunto sino a noi dopo un percorso millenario, subendo una serie di trasformazioni ed evoluzioni, sia di natura pratica che dottrinale. Se è vero che lo yoga delle culture indigene (II e III millennio a.C.) è stato poi assimilato dagli indoari, divenendo interiorizzazione di rituali vedici, per trovare le prime formulazioni teoriche nelle Upanisad (800-500 a.C.), è solo nei secoli a noi più recenti che lo Yoga ha subito una nuova “trasformazione” nell’incontro con la cultura occidentale.
Se Hatayoga Pradipika (La lucerna dello Hatha yoga), probabilmente datato al XV secolo e attribuito a Svatmarama, nella prima lezione ci dice che “Lo Hatha yoga è rifugio, come una cella monastica, per coloro che sono afflitti da tutti i tipi di sofferenza; lo hatha yoga è come la tartaruga che sorregge i mondi per coloro che praticano tutti i tipi di Yoga”, e che “Lo yogin che desidera la perfezione deve tener segreto in sommo grado la scienza dello Yoga, poiché essa, tenuta celata, è potente, ma divulgata perde il proprio vigore”, ci rendiamo facilmente conto di quanta sia la distanza tra lo yoga del presente da quello che ha rappresentato per secoli in regioni remote al nostro sentire. Indubbiamente lo yoga, che noi conosciamo oggi è anche – se non soprattutto - il risultato di un lungo processo di secolarizzazione, che è anche il fio che si è chiamati e scontare per poter accedere nel nostro tempo.
Ecco dunque tornare alla domanda posta in apertura del volume, dove Francesca Proia si e ci chiedeva, perché, oggi fare yoga? E diremo anche, che tipo di yoga fare?
Ho avuto il piacere di scrivere di questo libro proprio perché credo l’autrice sia riuscita nel non facile intento di rispondere a queste domande, per i motivi che ho cercato di esporre nel testo, presentando un volume che può essere di sicura utilità non solo per neofiti dello yoga, ma anche per praticanti conclamati ed insegnanti affinché possano approfondire alcune questioni teoriche dello yoga, senza tralasciare ovviamente la pratica, per l’importanza che abbiamo visto attribuita alla composizione delle tecniche come strumento per ritrovare una pratica viva.
Claudio Orlandi
Francesca Proia (1975), laureata in Conservazione dei Beni Musicali all’Università di Bologna, è coreografa, danzatrice e autrice. Ha lavorato come danzatrice per le compagnie Monica Francia, Habillé d’eau, Masaki Iwana; ha collaborato a lungo ed è stata assistente coreografa per il regista Romeo Castellucci. Tutto il suo lavoro è attraversato da un percorso di studio dello yoga che diviene una forma di ricerca poetica appoggiata sulle tecniche sottili. Nel 2016 debutta online il suo progetto “Mìnera, scuola di yoga in absentia”, dove i passi verso la comprensione dello yoga sono immaginati come minerali disseminati lungo il percorso dell’apprendimento dello scolaro. È docente presso Malagola, scuola di vocalità e centro di ricerche sulla voce diretta da Ermanna Montanari. Master Yoga Teacher registrata con Yoga Alliance, nel 2018 fonda “I vasi comunicanti”, scuola di alta formazione e ricerca yoga accreditata da Yoga Alliance.





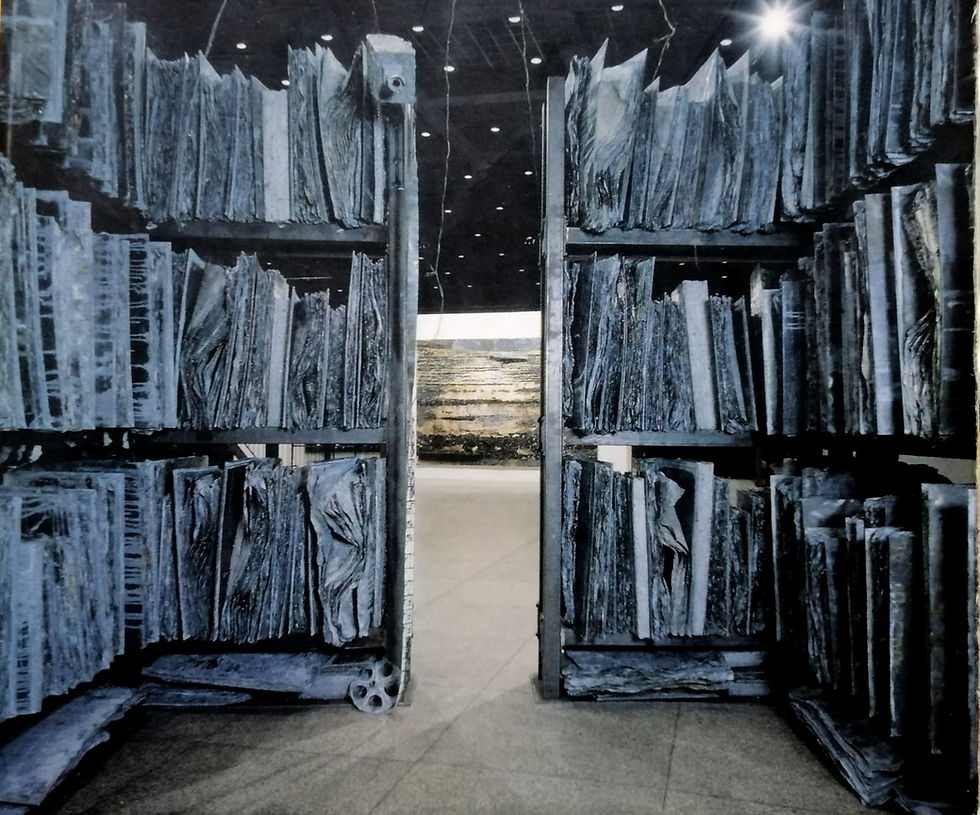

Commenti